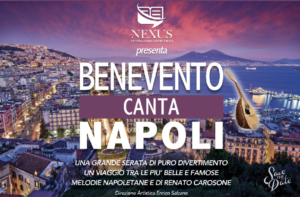CULTURA
“Arancia meccanica” e l’eterno ritorno della violenza

Ascolta la lettura dell'articolo
Film capolavoro datato 1971, tratto dal celebre romanzo di Anthony Burgess del ’62 e riadattato per il grande schermo da un geniale e sempre diversificato Kubrick. “Arancia meccanica” ha per protagonista Alex, capo dei “drughi”, una banda composta da quattro eleganti teppisti in bombetta e bretelle, con la naturale propensione per l’ultraviolenza. Nel film, ambientato in un “limbo” futuristico, Alex risponde al profilo del giovane incompreso dalla società dell’epoca, ma dotato di un’intelligenza superiore, colto e grande amante della musica classica, in particolare di Beethoven.
Dopo ripetute azioni di violenza ed un omicidio, Alex finisce in prigione, dalla quale riesce ad uscire grazie ad uno sconto di pena, dopo essersi ingraziato il cappellano del carcere, agli occhi del quale si era finto “rinsavito”. Egli deve, in cambio, accettare di subire il “trattamento Ludovico”, proposto da un sistema politico arrivista; un metodo in sperimentazione che attraverso l’ausilio di un terrificante dilatatore di palpebre, lo costringe alla visione di film brutali di stampo nazista, con la concomitante somministrazione di speciali gocce che inducono una straziante nausea e il vomito.
In questa maniera, a sua volta truce, il protagonista comincia ad accusare ribrezzo davanti a scene disumane, e non trova più la forza di compiere ulteriori atti di terrore. Secondo la classe dirigente Alex è “guarito”. Tornato in libertà scopre che la sua famiglia, oltre alla società, l’hanno abbandonato e tenta il suicidio. Verrà “fortuitamente” salvato dal marito di una sua ex-vittima, che coglie l’occasione per veicolare attraverso di lui il suo tornaconto politico, dimostrando di che trattamenti disumani il governo si è reso capace. Così il giovane Alex torna a delinquere, stavolta sorretto dal lasciapassare del sistema politico, molto più depravato dei teppisti dai quali è costretto a difendersi.
“Clockwork orange”, titolo originale in inglese, è una pellicola “immortale” che vista con gli occhi di oggi appare meravigliosamente insuperata, soprattutto per come il registra riesce ad inscenare, in un mix ben orchestrato e corrosivo, vandalismo, droga, sesso violento, perbenismo mascherato e a sublimarli attraverso la musica del grande Ludwing Van Beethoven. I suoi componimenti, infatti, fanno da sfondo alle scene più violente, un modo cerebrale e antinomico di Kubrick di esaltare con classe le scene più depravate con della musica eccelsa.
Il fatto più dirompente nell’architettura scenica del maestro è che, anche nelle scene di più drammatica violenza, manca la visione del sangue: le scene brutali si interrompono proprio un attimo prima del loro culmine. Neanche una goccia, difatti, occorre al regista per far salire la tensione, che è già ai suoi massimi livelli, convogliata insieme all’attenzione dello spettatore.
La scena principe del film è certamente quella di Alex che, mascherato si accinge a violentare una signora. Egli domina e, al contempo, sdrammatizza la scena più carica di violenza, ballando il tip tap e cantando “I’m singing in the rain”.
Discorso a parte va fatto per il Nasdat, il linguaggio inventato di sana pianta dall’autore del libro e che Kubrick riprende anche nella narrazione fuori campo. Uno slang per questo unico nel suo genere, macchinoso, futurista, come possiamo già renderci conto dalla sua resa in italiano: parole come “drugo”, ci suonano artificiali e dal sapore corroborante.
Un film molto complesso, di cui il regista ci offre mille modi interpretativi diversi, elargiti attraverso le sovrapposte visioni dei personaggi, ciascuno spinto ad agire dal suo personale interesse. In sostanza, una meditazione sul concetto di libertà dell’individuo e sui metodi che la società civile può e deve usare per stabilire un’ordine al suo interno. Ed il regista non può non porre al vaglio il punto di vista di un giovane come Alex, che si sente vittima della società e quasi “costretto” a compiere azioni truculente, come atto liberatorio nei confronti di un pessimismo che la vita gli ispira. Forse questa l’ottica più accreditata da Kubrick.
L’unica diversità che il libro può offrire rispetto al film è il finale edificante, che Kubrick decide di non riproporre nelle sue scene. L’Alex di Kubrick non è un ragazzo che alla fine, spinto dalle convenzioni sociali si sposa, ma rimane un eterno disilluso che non si sente a suo agio nell’adeguarsi ai dettami dell’ordine sociale. Un “frustrato” che prova soddisfazione solo nel compiere atti aggressivi, forse le uniche condizioni in cui riesce davvero a sentirsi non manipolato e, per questo libero.
Ilaria Iacoviello