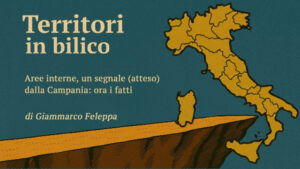CULTURA
Auser, al Palazzo del Volontariato l’incontro “La moralità della resistenza: l’esperienza di un partigiano sannita”

Ascolta la lettura dell'articolo
Si è tenuto il 3 novembre scorso nella Sede dell’AUSER-USELTE (Università Sannita dell’Età Libera e della Terza Età) presso il Palazzo del Volontariato di Benevento il quinto incontro in programmazione per l’anno sociale 2015/2016. Dopo una breve presentazione della Prof.ssa Maria Fiorito, il prof. Antonio Gisondi, docente di Storia della Filosofia c/o l’Università degli Studi di Salerno, ha trattato il tema: “La moralità della resistenza: l’esperienza di un partigiano sannita”.
Il docente ha illustrato approfonditamente l’originale e finora ignota esperienza del sannita Giuseppe Gisondi, (Dugenta 1923-2011), partigiano in Val Trebbia nel 1944 con il nome di Bosco. L’attento uditorio è stato subito catturato dal tema ampiamente trattato dal Presidente dell’Associazione Terre dei Gambacorta–ONLUS, che a Bosco ha dedicato il Quaderno n.6 del 2013.
La documentazione della sua intera vita che Bosco ci ha lasciato, prima da istruttore fascista fino al 1942 e poi da soldato (1942-43), fino alla scelta partigiana(1944) nella divisione Cichero, VI brigata Garibaldi, agli ordini di Bisagno (Aldo Gastaldi), “primo partigiano d’Italia”, fanno emergere una delle anime della Resistenza che spesso è stata sottaciuta o sottovalutata: la scelta partigiana come scelta o rivolta morale.
Pur provenienti da una quasi obbligata formazione fascistica, molti giovani, come Bosco, salgono in montagna, abbracciano la vita dei patrioti o ribelli, anzitutto contro quella stessa formazione, spesso contro i valori appresi o praticati in famiglia. Resistenza per questi giovani è anzitutto rifiuto di una visione totalizzante della vita che annullando radicalmente l’autonomia della volontà e la forza ragione individuale, ha distrutto la loro stessa soggettività e responsabilità.
E’ il rifiuto di ogni forma di verità assoluta, dogmatica, di fede, di partito, di razza, di religione: prima che contro il nazifascismo, quei giovani partigiani lottano contro l’oppressione o l’annullamento della coscienza individuale praticato da qualsiasi regime di massa, politico, militare, religioso, di destra o di sinistra.
La Resistenza è perciò una scelta morale che fonda la responsabilità individuale come valore irrinunciabile, a costo della morte. Come, infatti, scrive Bosco nel Testamento scritto il 23 aprile del 1944, “nell’ora incerta e tenebrosa” quando decide di salire dai ribelli perché “stufo di questa vitaccia senza ideali. Con quella scelta. Bosco, giovanissimo contadino del Mezzogiorno interno, severo istruttore dei giovani fascisti, figlio di un piccolo proprietario fascista “centurione di Cristo”, salendo in montagna ha scelto di lottare anzitutto contro il suo stesso passato. Ma non altrettanto avviene al suo “paesello” dove quei suoi allievi dopo il 25 aprile del 1943 da giovani cresciuti nel totalitarismo, rifiutano quello fascista in fallimento, per abbracciarne però un altro, opposto e simile, per il momento vincente, quello comunista.
Anche questo visto come capace di realizzare la palingenesi sociale, la rivoluzione, il mutamento dell’ordine mondiale. Inoltre, mentre Bosco, a rischio della vita sale in montagna in nome della sua riconquistata autonomia di soggetto morale, la sua famiglia lontana non solo non matura il rifiuto del fascismo, ma convive poi con il postfascismo che al sud significa ritorno al potere di tutti i fascisti, offuscati solo per un attimo.
Bosco, ritornato a casa nel dicembre del 1944 a guerra ancora in corso, perché affetto da scarlattina attraversando però a piedi l’intera penisola in un mese, da ex fascista, da partigiano si trova a dover vivere nel postfascismo, anche familiare, mentre i suoi ex allievi sono diventati comunisti.
Ora non gli resta che “desistere”: questo sud tomba della Resistenza. E in una fossa sottoterra il ribelle Bosco dovette nascondersi per diversi mesi contro gli opposti totalitarismi che si ostinano a cercalo.